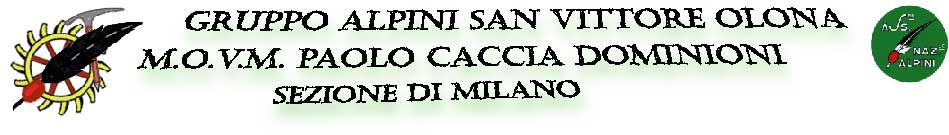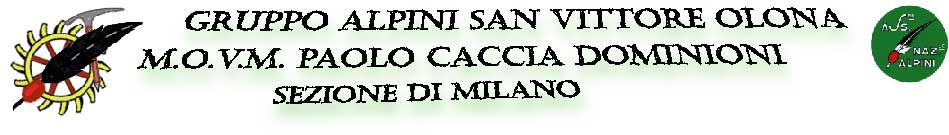LA DOPPIA NAJA
Parlavo un giorno con un mio carissimo amico residente nel Veneto, in un paese a ridosso delle verdi colline trevisane, per intenderci quelle del prosecco, e che prosecco, quando ci si trovò casualmente a commentare sui nostri emigranti all’estero, su quelli della doppia naja. Tengo a precisare che il mio interlocutore è stato uno sten dell’artiglieria alpina per cui il nostro dialogo ed intesa sono supportati oltre all’amicizia, anche dalla comune appartenenza all’associazione alpina. Detto ciò vengo al punto, quando lui uscì con un’espressione " ma hai mai pensato che anche tu e la tua famiglia avete provato l’esperienza della doppia naja?" sul momento mi spiazzò con tale affermazione. Infatti, di primo acchito, tutti noi pensiamo che il termine “doppia naja”, nel linguaggio alpino, si riferisca esclusivamente ai nostri emigranti costretti a lasciare l’Italia per ogni parte del mondo. Fin qui tutti d’accordo ma riflettendoci un po’ di più credo che il mio amico non avesse tutti i torti. Salve le debite proporzioni, a “quei” tempi andare in America, Canada, Argentina, oltreoceano o nelle miniere del Belgio, nei campi in Francia ecc. non era uno scherzo ma neanche per quanti costretti a lasciare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Istria, ecc… Infatti il trasferirsi nella bonifica delle paludi pontine del Lazio, nelle fabbriche del Piemonte e della Lombardia ecc.. non era un’impresa da poco, d’altra parte erano le ultime carte che potevano giocare: rimanevano sì in Italia ma con analoghe difficoltà di quanti si allontanavano oltremare. Le realtà da affrontare per quella gente sono state semplicemente enormi a partire dalle distanze quasi insormontabili, andate senza ritorno, ai dialetti, all’adattarsi e ricominciare tutto daccapo in ambienti totalmente diversi e chi più ne ha più ne metta. A titolo di sfida potrei suggerire “provare per credere.” Avevo circa 5 anni, siamo nel 1953, quando una ragazza di una fattoria presso di noi ( presso si fa per dire date le distanze tra una fattoria e l’altra ) partì per trasferirsi a Vigevano e sposare il fidanzato allontanatosi precedentemente in avanscoperta per lavoro Al momento dei saluti, anzi meglio, degli addii, ricordo i vicini che fra le lacrime esclamavano " non ti vedremo più" Oggi Rovigo-Vigevano “ che ce vò ”, ma nella memoria mi ritorna spesso quel commiato, io ero un bambino, non capivo fino in fondo quel momento, quegli addii, ma erano gli adulti che piangevano e ovviamente comprendevano più di me. Quel Vigevano così lontano e così misterioso. Anno dopo anno molte famiglie, come la mia, partirono: i motivi furono infiniti e fra i tanti anche la piena del Po che mise in ginocchio il Polesine.
La Lombardia ci offrì posti di lavoro ma non poté cancellare le difficoltà dell’adattamento magari in case d’emergenza, del dialetto, e specialmente, per i tanti arrivati dalla libertà e dal profumo dei campi, la timbratura del mattino , i sistematici turni di notte, chiusi in stabilimenti dove l’odore della pelle e della colla-cemento nei calzaturifici, dell’umidità nelle tessiture, dell’anonimato alle catene di montaggio si assommavano con la problematicità del comprendere il linguaggio popolare. Le istruzioni dei colleghi o i comandi dei capireparto, sovente e purtroppo, erano avvelenati dalle accuse di rubare il mestiere, so per certo di furiose scazzottate per tali motivi. Riandando a quei tempi, alle fatiche, alle incomprensioni e tanto grigiore finalmente oggi e, fortunatamente meno male, possiamo anche sorridere un po’ quando un mio conoscente uscì di corsa sulla strada per comperare delle mele aveva sentito una specie di “ortolano” che sulla strada, dalla sua caretta, urlava:" pomme de terr" peccato vendeva patate ma il mio conoscente cercava le mele e nel suo dialetto le mele si chiamavano “ pomi”. Per finire, andando un attimo sul personale, anni ed anni fa, un’eternità, quando i miei suoceri, mi spiegavano il significato del “purtà i benis, della scighera, del burdiumm , dei scalfaroti, ecc…", una specie di scuola serale, quasi un teorema di Pitagora. Concludendo: solo quattro righe, sulla nostra seconda naja: forse non interesseranno a nessuno ma, credetemi, è stata dura.
Pio